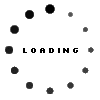I pazienti che manifestano il tipo di disturbi riconducibili al DAP (Disturbo da Attacchi di Panico), si presentano allo psicologo dopo una serie di richieste d’aiuto volte sia al medico curante sia ai vari distretti d’emergenza. Questo perché il disturbo che si manifesta col panico non presenta avvisaglie. Non ci sono periodi precedenti l’esordio vero e proprio, con sintomi ridotti; a meno che non vogliamo far risalire all’ansia più o meno grave questo ruolo per così dire propedeutico. Ma l’ansia accompagna troppi disturbi per potersi considerare distintiva di qualcuno in particolare. Penso valgano le stesse considerazioni per la paura. Non è la stessa cosa per l’aggressività espressa o coartata. La maggior parte delle osservazioni che posso vantare depongono per una presenza notevole di aggressività non espressa. Mi sono persuaso che proprio dall’aggressività, che si ha timore di esprimere, derivi il formarsi della sintomatologia che va sotto il nome di attacchi di panico.
Se assumiamo questo punto di vista diventa facile capire anche il motivo per cui la cura di questo disturbo è rivendicata da gruppi di “auto-mutuo-aiuto”; gruppi autocostituiti che fino a qualche tempo fa nascevano sotto la spinta di disturbi di tipo sociale e/o relazionale o più di massa cioè per i quali c’è una maggiore possibilità autodiagnostica e spesso non sono considerati di competenza degli “strizzacervelli” (alcolisti anonimi e mangiatori anonimi). Parlando di “aggressività non espressa” stiamo già parlando di problemi relazionali e infatti penso che il DAP sia il disturbo della relazione per antonomasia.
Genesi
Ognuno di noi ha la sensazione di un rapporto di continuità col proprio passato. Malgrado l’evoluzione e la crescita si attuino per mezzo di processi di cambiamento, noi siamo convinti d’essere sempre noi stessi. Il nostro senso d’identità rimane costante. Viene spontaneo chiedersi allora cosa è a rimanere sempre uguale e a darci questa sensazione di continuità.
Dal concepimento in poi le cellule del nostro organismo cambiano costantemente e i vari organi “esitano” solamente in forme strutturalmente definite (Ruggeri, 1997). Ciononostante siamo anche vissuti da un sentimento di “esistere” che accompagna il realizzarsi delle funzioni dell’organismo che noi siamo.
Questo sentimento ci dà il senso di continuità; è ciò che chiamiamo “il senso di Sé”. Come il sentimento che accompagna lo svolgersi delle funzioni è riconducibile al Sé, al sentirsi dell’organismo, l’Io è riconducibile al sentimento che nasce a seguito della “integrazione delle funzioni” e al suo riconoscimento.
Alla nascita ogni bambino si ritrova non solo con un corredo genetico completo ma anche con organi tutti funzionanti. I sistemi più importanti sono già definiti mentre la maturazione nervosa si completerà solo dopo la nascita, una volta che l’organismo è calato nell’ambiente in cui dovrà vivere.
La dotazione organica è notevole ed ogni organo è capace di molte competenze; ciò che manca all’insieme dell’organismo è la coordinazione degli organi volontari. Sono presenti alla nascita tutti i riflessi essenziali, da quello rotuleo all’ammiccamento oculare, a quello prensile, ma il bambino non è ancora capace di coordinazione e quindi non sa seguire un oggetto con ambedue gli occhi, non sa portare alla bocca un oggetto e non riconosce la propria mano in quell’organo che apre e chiude davanti ai suoi occhi.
Per tutto il periodo della gestazione queste competenze non sono state necessarie. Diventano importanti dalla nascita e successivamente caratterizzano anche le modalità relazionali e l’autonomia del nascituro. È da questo momento infatti che viene chiesto al bambino l’esercizio e il movimento coordinato dei propri organi e, cosa più importante, gli viene chiesto di farlo in maniera intenzionale. In questo modo il bambino è indotto a sperimentare-si e impara a ri-conoscere gli organi, i propri organi.
Il bambino è indotto a ri-conoscersi (riconoscere sé) da una figura molto importante e da cui dipende totalmente. Il bambino impara contemporaneamente, perché ama e dipende da chi ama, che è fatto di organi autonomi e che questi pezzi di sé possono essere messi insieme a formare uno “schema” più complesso di comportamento.
È nella relazione che è promossa “l’intenzione”. L’intenzione si lega e nasce dal vissuto di piacere che a sua volta deriva dalla ricompensa che il bambino vive nello scoprire di poter gestire la realtà coordinando il movimento di quelle parti del proprio organismo. Forse in questo momento scopre anche il senso del possesso e “dell’essere” padrone…
Insieme al piacere della scoperta di poter intervenire nella gestione della realtà, che lo mette in relazione con l’esterno (dal cui confronto nasce l’Io), è possibile ipotizzare per il bambino un piacere più sottile e profondo che accompagna questi eventi, ed è quello di scoprirsi capace di una “integrità”, di un’interezza. Il piacere narcisistico del “tenersi insieme” (1).
Quindi possiamo dire che il bambino “si vive” nei propri organi funzionalmente separati; anche se maturi, inizialmente questi organi non sono riconosciuti come “Io”. Poi, nel momento in cui sperimenta la possibilità di comporre movimenti più complessi e coordinati, scopre sia gli organi sia il piacere di muoverli insieme in modo integrato e coordinato. Il piacere narcisistico accompagna la nascita dell’Io.
Il vissuto che accompagna quest’esperienza sarà un sentimento d’integrazione progressiva che si accompagna al riconoscimento, per contrasto, del sentimento iniziale di “non-integrazione”(2).
Quando siamo stanchi e provati, la messa in atto di comportamenti più elementari corrisponde al processo della regressione per mezzo della quale si attua un recupero energetico. Da questo punto di vista le modalità di funzionamento regressive, richiedendo meno impegno, sono anche modalità di recupero energetico. È come se dicessimo che le modalità di funzionamento più mature, cioè l’Io per poter esistere e le sue funzioni per poter essere mantenute attive, avessero bisogno di costante attenzione e impegno per cui, quando siamo stanchi e/o stressati, possiamo “mollare” e lasciare che subentri un modo di funzionare più semplice.
Del resto non potrebbe essere diversamente considerando tutto l’organismo un evento processuale; un processo più evoluto conserva le modalità di funzionamento degli elementi che lo compongono per cui possiamo dire che vivere ad un certo livello dell’evoluzione e di organizzazione organismica, richiede l’esistenza di un certo “lusso energetico”. In alcuni questo livello di organizzazione energetica viene vissuto come “sforzo”. Non riuscendolo a sostenere si adottano procedure regressive con la corrispondente adozione di comportamenti precedenti e più elementari. In questi casi però c’è un rischio; è possibile che il ritorno regressivo ai comportamenti precedenti riattivi vissuti arcaici di sviluppo evolutivo che ricordano i momenti di non-integrazione. Il rischio è che anziché rivivere questa esperienza come il ritorno alla non-integrazione la si possa vivere come una caduta o un precipitare nel vissuto della “disintegrazione”.
1 – “Il narcisismo, che è un processo presente insostituibilmente in tutti gli umani, ha dunque per noi le sue radici nella corporeità, e si sviluppa attraverso l’intervento di meccanismi legati all’esperienza del piacere… Il piacere narcisistico è piuttosto assimilabile a quello che si chiama “istinto di vita”: è il piacere che deriva dall’integrazione degli eventi corporei che, nella forma di istinto di vita, è generato dalla necessità biologica di “tenerli insieme” e di dar loro “unità”. (Ruggeri, 2001, 99).
2 – “La disintegrazione della personalità è un ben noto stato psichico, e la sua psicopatologia è molto complessa. L’esame di questi fenomeni in analisi, tuttavia, mostra che lo stato primario di non-integrazione è alla base della disintegrazione” (Winnicott, 1991, p. 180).
Diagnosi differenziale
In genere è difficile legare gli eventi DAP a momenti specifici della propria storia personale perché evidentemente qualcosa relativo ai “legami” è stato compromesso ed è diventato difficile il recupero dell’esperienza passata. Quando parliamo di “esperienza” ci riferiamo sia ai “comportamenti” osservabili sia alle emozioni e ai sentimenti che li accompagnano. All’inizio della vita extrauterina le emozioni non sono affinate ed è dal piacere e dal dolore che si svilupperanno la rabbia, l’odio e l’amore. In questo periodo, quando il bambino scopre di esistere, lo fa attraverso gli occhi e lo sguardo di coloro che gli vogliono bene. È attraverso loro che scopre il piacere di esistere e con loro comincia e rivendicare e a scoprire il piacere (narcisistico) di realizzare le proprie intenzioni.
In che modo avvengono queste scoperte? Prima di scoprire la possibilità di realizzare le proprie intenzioni il bambino scopre, negli occhi della madre, il “piacere” della realizzazione del suo (di lei) desiderio. All’inizio è lei che mostra piacere o disappunto indipendentemente dall’intenzionalità del bambino nel realizzare qualsiasi comportamento. È lei che comincia il gioco di desiderare che lui realizzi cose. S’instaurano i primi i primi giochi relazionali in cui il bambino scopre il piacere d’essere chiamato in causa. Scopre che i richiami, gli appelli sono rivolti a lui e solo a lui ed è il piacere e il desiderio della intenzionalità, che lui compia delle azioni intenzionali, scritti negli occhi della madre, che il bambino legge e alla fine cerca e riesce a fare propri.
Ma come riesce un bambino a fare propria l’emozione materna? Ad incorporarla ed introiettarla? Una delle competenze ereditate geneticamente dai bambini è quella del riconoscimento dell’emozione attraverso l’imitazione. Sembra che i bambini posseggano questa capacità fin dal primo giorno dalla nascita (Goleman, 2004). Secondo alcuni assunti neurofisiologici (Ruggeri, 1997) l’empatia è un sentimento i cui correlati neurofisiologici sono attivati nell’esperienza imitativa. Forse è questo a spingere il prof. Ruggieri a definirla “decodificazione imitativa”. Allora forse, se l’empatia è una funzione corrispondente ad organi già presenti alla nascita, vuol dire che la condizione del suo sviluppo è l’esercizio ed è per questo forse che possiamo anche “dimenticare” d’essere empaticamente competenti, per mancanza d’esercizio. Oppure possiamo anche non aver mai imparato. Manca l’esercizio quando non ci sono stimoli adeguati. Al bambino non è offerta l’opportunità dell’esercizio di una funzione.
I processi precursori dell’empatia presenti alla nascita sono tecnicamente definiti “mimetismo motorio”. Probabilmente è con l’utilizzo di questi processi che il bambino porta dentro di sé il desiderio materno o, per meglio dire, costruisce dentro di sé il desiderio corrispondente all’immagine di ciò che vede riflesso negli occhi, nella voce e nel volto delle persone care. Le prime cose che desiderano le persone che si prendono cura del bambino, per il bambino, sono legate all’evoluzione. Il primo desiderio di ogni genitore è scoprire che il bambino è capace di apprendere.
Ogni sua più piccola conquista è accompagnata da manifestazioni di gioia. Queste manifestazioni fungono da rinforzo perché il comportamento si ripeta e sempre meglio.
Il sempre meglio sta per “sempre meglio integrato” corrispondente alle esperienze attraverso cui il bambino impara a coordinare il movimento del proprio corpo e dei propri organi nello spazio in relazione alle persone ed agli oggetti e finalizzando tutto al perseguimento di un obiettivo.
Scoprendo di “voler fare” il bambino scopre se stesso e scopre che il suo piacere, nel realizzare l’integrazione degli organi del suo corpo e delle funzioni di questi organi, corrisponde al piacere antico intuito negli occhi della madre. La gioia della madre per la sua riuscita sarà la sua gioia.
Quindi, sintetizzando possiamo dire che il bambino dalla nascita scopre i propri organi; che attraverso l’esercizio del mimetismo motorio scopre le emozioni dei genitori e costruisce l’empatia; si appropria delle loro emozioni e scopre la gioia di poter agire,con intenzione, sulla realtà attraverso il processo di integrazione dell’Io. E scopre anche una cosa che ha per noi un grande valore esplicativo ai fini della costruzione di un’ipotesi sulla genesi del DAP: scopre che il costante sostegno e desiderio che i genitori manifestano in direzione del perseguimento dell’integrazione dell’Io, funge da collante tra le stesse funzioni per cui il bambino lega le funzioni che “sente” maggiormente valorizzate. Per questo la partecipazione, l’interesse, la disponibilità, la presenza, il contatto di coloro che si prendono cura del bambino, sono strumenti utili a rafforzare il formarsi dell’Io (integrato), mentre al contrario, l’assenza, la mancanza di disponibilità eccetera conducono a disturbi corrispondenti all’atrofia, alla dimenticanza, a poca dimestichezza nello svolgimento di funzioni specifiche.
In questa dinamica energetica anche i pre-giudizi, le convinzioni, la fede che i genitori hanno nei confronti della possibilità del bambino di realizzare le opportune integrazioni e apprendimenti, li condizionano. È il desiderio e la fiducia della mamma nella capacità del figlio che lo rendono veramente capace di realizzare i suoi desideri (della madre) che poi diventano anche del figlio. Di solito diamo per assodato che i genitori siano convinti delle reali possibilità del figlio di realizzare gli eventi maturativi. Invece nella realtà il giudizio dei genitori, quello che sentono e pensano rispetto al figlio, è sempre condizionato dai sentimenti che vivono nei suoi confronti, e in genere, nella relazione col figlio, ogni genitore porta anche i sentimenti non elaborati e i bisogni non soddisfatti dalle relazioni avute col/nel suo mondo. Anche quella col figlio quindi è una relazione colorata dal proprio mondo interno ed anche con lui si esprimono bisogni di dipendenza e regressione infantile. Molte insoddisfazioni possono venire a galla e i propri bisogni si impongono in modo più impellente di quelli degli stessi figli. I genitori possono ritrovarsi ad essere troppo presi dalla propria realtà e distratti nei confronti dei figli.
Inoltre capita a tutti nella vita di scoprire che ci sono periodi alti e bassi e a tutti può accadere che, pur essendoci disponibilità, amore e attenzione, ci possono essere periodi in cui anche le persone che si prendono cura di un bambino sono presi da altro e inavvertitamente cambiano il loro modo di rapportarcisi.
Per una madre può esserci la nascita di un altro figlio, un problema di lavoro, il decesso di una persona cara, insomma eventi che possono distogliere l’attenzione dal bambino riducendone l’investimento affettivo. Del resto è un normale modo di relazionarsi quello che prevede il graduale disinvestimento genitoriale e serve ad educare all’autonomia. Solo che questo disinvestimento non sempre si realizza nel momento opportuno né nei modi in cui il bambino può tollerarlo.
In questo periodo della propria esistenza la sua vulnerabilità è notevole. La vita si limita al rapporto instauratosi con le figure primarie e, in alcuni casi, qualsiasi cambiamento che non tenga conto del periodo evolutivo e delle modalità di relazione del bambino, è suscettibile di ingenerare un vissuto drammatico che produce un grosso dolore e paura.
Il dolore e la paura generano la rabbia che non può comunque dirigersi contro le persone da cui si dipende perché rimangono sempre gli oggetti più significativi della propria esistenza; attaccarle significherebbe rischiare di distruggerle, di fargli del male e questo non può essere, non può avvenire. Nasce un conflitto il cui esito porta a rivolgere questa rabbia contro se stessi. C’è un’inversione di tendenza. Aggredendo se stessi si realizzano diversi obiettivi: si scarica la rabbia; si punisce colui che vive la rabbia e desidera fare del male alle persone cui si vuole bene; si fa anche del male all’oggetto cui i genitori vogliono bene, quindi li si ferisce indirettamente.
Quando le esperienze di questo tipo, di disattenzione genitoriale, di disconferma o di trauma, sono frequenti o molto intense o durano per troppo tempo, è possibile si formino delle personalità dubbiose; con poca fiducia e spaventate dalla realtà, sempre sulla difensiva. Sono persone costantemente attente a controllare tutto e tutti e tese a tenere in un insieme coerente, con tutte le loro forze, le componenti emozionali e cognitive del mondo che si sono costruiti.
Sono persone costantemente sottoposte a stress emozionali e fisici perché si sobbarcano di tutti gli oneri di un’autonomia di cui non sono capaci o alla quale sono impossibilitati; cercano di dimostrare di poter fare tutto da soli, come immaginano che vogliono i loro genitori; di non aver bisogno di alcun aiuto pratico né affettivo; tengono a bada le emozioni e la loro espressione perché hanno interpretato il voltafaccia o il disinteresse o la disattenzione genitoriale come una richiesta tacita di crescita e autonomia. Pur non avendo mai vissuto una vera e grave separazione vivono paventandone sempre una. Sono quindi persone sempre in allarme e impegnate a vivere al massimo delle proprie possibilità.
Probabilmente proprio questo “massimo costante sforzo” rende loro impossibile realizzare qualunque progetto. La tensione e l’ansia derivanti da questa modalità di approccio alla vita sarà energeticamente depauperante perchè si esaurisce nel tentativo del controllo.
Il naturale sentimento di fiducia nelle proprie possibilità, non essendo stato alimentato dai genitori distratti, presi altrimenti, arrabbiati, insoddisfatti, delusi, è frainteso e viene sostituito da quello del controllo. Certamente perché c’è anche più dimestichezza con questa pratica piuttosto che l’altra.
Qualunque vera separazione o anche solo il rischio di una vera separazione, che potrebbero anche essi stessi giudicare e sentire come necessaria, una perdita improvvisa o anche solo il rischio di una perdita, mette questa persona davanti alla realtà del proprio vissuto d’impossibilità a “farcela” a sopravvivere e può scatenare un attacco di panico.
Gli attacchi di panico hanno esordi improvvisi ed inaspettati. Questi momenti di acuta ansia non durano moltissimo ma comunque il tempo sufficiente a stabilizzare un sacro timore che l’evento possa ripetersi.
Non ci sono motivi oggettivi di scatenamento; il pericolo e il terrore che si racconta di vivere è solo un tentativo di descrivere l’emozione, che si crede, dovrebbe accompagnare le sensazioni disgreganti che si sperimentano. La paura è terribile perché è di morire e non ci sono parole capaci di rendere conto efficacemente del vissuto e in maniera credibile. In quel momento non è l’individuo a vivere l’attacco di panico bensì, al contrario, ne è vissuto. Si ha paura della follia e della perdita di controllo perché quello che si sta vivendo “è” follia, “è” al di là di sé. L’Io con tutte le sue capacità di controllo, razionalità, lucidità ha abdicato o si è anche lui nascosto da qualche parte. La tempesta infuria e devasta i ritmi, sconvolge i confini.
Ogni parte del corpo va per conto suo, diventa pesante, stanco, estraneo e “quelle strane sensazioni” diventano indici di una volontà che è dentro di noi ma non siamo noi; non la riconosciamo come nostra. Nasce la paura della follia e di non poter essere artefici di noi stessi nelle esperienze future. Si autoalimenta la sfiducia. Comincia una lotta immane ed estenuante tra il cedere, lasciare andare e lasciarsi andare o tenere/tenersi sotto controllo. Il “sapere” dell’irrealtà del sintomo non basta a tranquillizzare; tachicardia, senso di soffocamento, blocco allo stomaco, contrazioni viscerali, disturbi alla vescica, tremori agli arti, tutte sensazioni, forse non reali, ma non per questo meno vere.
Dopo le prime volte, la diagnosi ufficiale, “sindrome da attacchi di panico”, diventa anche una condanna perché è come se questo disturbo venisse catalogato tra quelli di fantasia, non reale, inventato. Chi non l’ha mai vissuto non riesce a capacitarsi della veridicità delle sensazioni e dei vissuti raccontati e allora accade che questi disturbi vengono vissuti in solitudine, là dove matura il pudore a confessare la numerosità degli attacchi e la loro gravità. Quando poi non si arriva anche a sentirsene in colpa.
Nella relazione si cerca la sicurezza sulla quale comunque ci si riserverà sempre qualche dubbio. Si tende alla simbiosi e all’approvazione degli altri. Si temono le emozioni bloccando in modo particolare l’espressione dell’aggressività; si tende al conformismo sociale e si sacrifica la creatività.
La cosa che più di tutte si evidenzia è il legame tra angoscia di separazione e panico.
Attacco ai legami dell’Io come presupposto per il DAP
L’approccio terapeutico alla sindrome parte sempre da un’ipotesi e questa può essere formulata a partire dall’osservazione del comportamento e dai vissuti fenomenologici. È per questo che ogni intervento deve essere preceduto da una breve indagine diagnostica. A volte è anche possibile ci siano manifestazioni sindromiche simili che, pur appartenendo allo stesso quadro diagnostico, possono poi rivelare una diversa genesi dinamica e perciò diventa importante che la diagnosi sia anche capace di leggere una differenza nel formarsi di un certo quadro nosografico.
Nel DAP ci colpisce quanto ci viene riportato circa un vissuto di separazione tra l’espressione corporea e la capacità di riconoscere l’emozione rappresentata. L’unica emozione riconosciuta alle diverse attivazioni fisiche (tachicardia, soffocamento ecc.) è la paura. Le persone affette da panico nelle sue varie manifestazioni, non sono in grado di risalire alle emozioni che hanno scatenato quelle attivazioni neurofisiologiche ma riescono unicamente a riconoscere quella da esito finale. È possibile supporre che proprio il mancato riconoscimento emozionale porti ad una sensazione di estraneità sensoriale che, alla fine, è riconducibile alla paura.
Un altro elemento distintivo che può assumere valore differenziale nel DAP è il fatto che, mentre nelle forme di attivazione somatica riconducibili all’isteria l’investimento riguarda l’organo e la funzione specifica relativa, in modo che il sintomo assume un proprio linguaggio e una propria comunicazione alternativa rimandando sempre a qualche altra cosa (il sintomo sta per qualche altra cosa), nel panico ciò che viene investito affettivamente è il legame tra le funzioni dei diversi organi. È investita la funzione di raccordo e il legame tra le stesse funzioni che in tal modo perdono di senso e significato. Proprio questo investimento dà conto sia del valore aggressivo di quest’affetto sia della valenza relazionale del DAP.
Tutto ciò ci conferma ulteriormente anche rispetto a quanto accennato a proposito dell’empatia; cioè che le funzioni dipendono dall’esercizio e dall’utilizzo che ne facciamo e che, ora possiamo dire, è innanzi tutto relazionale.
Nel tentativo di spiegarci cosa accade negli eventi di DAP proviamo a dire che i processi fondamentali del nostro organismo sono relativi alle funzioni del “legare” e “separare”. L’abbiamo visto un po’ in opera nell’evoluzione e abbiamo anche visto che queste due funzioni operano anche a carico di ciò che costruiamo dentro di noi. Una volta scoperto l’uso che possiamo fare delle varie istanze, emozioni, sensazioni e funzioni che formano il nostro organismo, leghiamo e mettiamo insieme quello che è fuori di noi e quello che viviamo dentro. Quest’operazione la realizziamo sia a livello psicologico che corporeo anzi al contrario, sia a livello corporeo che psicologico, perché è dalle esperienze corporee che partono le informazioni che alla fine “mentalizziamo” per sintesi progressiva. Le funzioni del “legare” e “separare” si legheranno e avranno una corrispondenza con le sensazioni e con le emozioni così che possiamo parlare di una sorta di “corporeizzazione”. Cioè, contrariamente a quanto può suggerire il termine, le emozioni possono essere comprese solo dopo che le abbiamo sentite nel corpo e abbiamo imparato a conoscerle. Il che vuol dire che ciò che sentiamo nel corpo ha sempre un correlato e un significato emozionale; solo che può essere subentrata una difficoltà a ri-conoscerlo. Un’interruzione tra il sentire e il capire.
Ciò che negli attacchi di panico determina questo scollamento è la rabbia rivolta contro l’Io e le sue funzioni. In queste persone quando l’evento separazione, o la sua possibilità, si produce realmente, sotto forma di un’eventuale decesso, allontanamento da persone care, realizzazione di un progetto d’autonomia (tesi di laurea, diploma), matrimonio o anche si presenta in forma simbolica (un viaggio, un volo, un conflitto relazionale) e sono in un momento di stress fisico o psicologico, scatta l’attacco di panico derivante da un vissuto di dolore cui corrisponde una rabbia che non può essere indirizzata verso l’oggetto scatenante in quanto è lo stesso oggetto visto e perseguito come gratificante. Questa rabbia viene allora diretta verso l’Io, che è “un’integrazione di funzioni”, menomandone la capacità legante in quanto è proprio questa capacità che rappresenta, in quel momento, l’inverso del processo che sta generando la rabbia (la separazione) e, per l’inconscio, l’inverso di una cosa è la cosa stessa; si realizza con questa modalità l’aggressione dell’evento separazione che fa stare male.
L’aggressione dell’Io rappresenta per questo disturbo anche l’aggressione dell’oggetto condiviso dalla nascita con la figura primaria di relazione; con il primo campo “madre” il bambino condivide la gioia e il piacere narcisistico dell’integrazione. Aggredire l’Io può equivalere, per il bambino, ad aggredire in sé il desiderio materno della crescita e dell’autonomia.
Una diagnosi energetica rivelerà in queste persone una buona tonicità, tendenze affermative e atteggiamenti risolutivi che rimarcheranno tenacia la quale può indurre a errate valutazioni diagnostiche di masochismo morale. Queste persone non sono masochiste perché non godono nello star male e nel non riuscire a realizzare i propri obiettivi. Anzi ne soffrono e se ne affliggono e l’autodenigrazione è solo un’ulteriore manifestazione della rabbia autodiretta.
Quando invece siamo effettivamente in presenza di una bassa energia, è possibile si realizzi una pura difficoltà dell’Io a realizzare una costante integrazione delle funzioni fisiche e mentali. Eventuali esaurimenti fisici e/o psichici possono manifestarsi con attacchi di panico. Però non possiamo ancora dire d’essere in presenza di una sottostante o evidente depressione perché questa carenza investe le capacità dell’Io e non quelle del Sé.
Queste persone sono persone che s’impegnano e si danno da fare ma sono facilmente vittime della stanchezza, dell’esaurimento, della difficoltà di concentrazione, mancanza di costanza e può capitare che siano anche destinate ad essere soggette ad errate diagnosi di depressione.
Il DAP copre invece una vera depressione quando l’aggressività, l’animosità e la rabbia sono rivolti al Sé, al sentimento che accompagna la sensazione di esistere. In questo caso l’individuo è svuotato di senso anche se ugualmente può essere preda di senso di perdita, dispersione e disintegrazione. L’Io in questo caso è come se “recitasse il panico” con lo scopo di trovare un conforto, un legame, un’accoglienza che possa riuscire a dare un senso relazionale all’esistenza. È proprio il valore relazionale che assimila queste due manifestazioni.
Per questa serie di considerazioni possiamo dire che le persone destinate all’attacco di panico, lo possono incontrare ogni volta che vivono una relazione nella quale c’è il rischio, anche solo paventato, della separazione. Si può dire che questo evento è così tanto temuto che si impegnano a tenere insieme la relazione ostinatamente anche “faticando moltissimo” e al limite delle proprie capacità, sacrificando tutti i propri bisogni e desideri.
La problematica della separazione è quindi principe in questo disturbo presentandosi a tutti i livelli di relazione; “mettere e tenere insieme” le cose e le persone sono i processi maggiormente perseguiti perché maggiormente meritevoli e necessitanti di riparazione.
Nemmeno rilassarsi è possibile per queste persone perché il relax si accompagna ai vissuti di regressione psicofisica e regredire, per loro vuole anche dire “tornare a modalità di funzionamento precedenti”. Quelle “modalità di funzionamento evolutivo” precedenti sono proprio le modalità di non-integrazione infantile che queste persone vivono con allarme e paura perché, per loro, l’allentamento dei legami tra le funzioni si accompagnano a vissuti di rabbia rivolta all’Io come rappresentante simbolico di oggetto d’amore condiviso e quindi sono vissuti di disintegrazione e perdita.
Da qui la paura di perdersi, rompersi e frammentarsi; la paura d’impazzire.
La paura di “non sapersi controllare” che l’attacco di panico provoca, è quindi da mettere in relazione alla paura di non sapersi più tenere insieme e alla paura che l’Io perda la capacità di “controllo funzionale”. Nel DAP quindi non è messo in discussione l’autocontrollo come funzione Super egoica, ma il controllo come funzione dell’Io.
La lotta evolutiva di queste persone è tesa a dimostrare-si capaci di un’integrazione di cui non sono per niente sicure. E non ne sono sicure perché nella relazione con i genitori non hanno avuto sufficienti conferme della loro “capacità/possibilità” di farcela. Forse inizialmente i genitori erano distratti o presi da altro, poi disinteressati, poi da più grandi li hanno disconfermati e non è raro infatti che si siano trovati davanti a vere e proprie competizioni con le figure genitoriali nel cui confronto hanno cercato e tuttora cercano di mostrarsi più capaci e più bravi di gestire la famiglia, la professione, la relazione. Competizione che a sua volta esaspera ed alimenta rimproveri e ritorsioni genitoriali.
Questa competizione permane tanto a lungo che a volte si rivela ancora attiva nel perseguimento problematico e forzato dell’autonomia anche nell’età adulta e, proprio perché forzata, si risolve spesso in esiti disastrosi.
Questa dinamica, relativa all’Io, si lega alla fiducia piuttosto che al controllo.
La capacità di controllo è ciò che la società in genere ci chiede; è un appello alla forza, all’impegno energetico. Ci chiede di rinsaldare e fortificare i limiti, i confini del nostro organismo e non lasciare uscire né entrare elementi estranei. Si fa appello implicitamente alla rigidità che può stare anche per “chiusura”, forza, impenetrabilità, per corazza, anche caratteriale direbbe Reich. Nel richiamarsi al controllo si fa più appello alle istanze riconducibili al Super-Io piuttosto che all’Io.
Ma la rigidità si lega alla fragilità ed è proprio questa la caratteristica che incontriamo nelle persone preda degli attacchi di panico quando coltivano il controllo piuttosto che la fiducia. Sono al contempo forti e fragili. Danno l’impressione di potersi fare carico di qualunque cosa tanto da destare l’incredulità, la sorpresa e il disappunto, anche in chi li conosce da tempo, quando poi crollano.
In questo cerchio si autoalimenta la sfiducia.
È per questo che in queste persone non può e non deve essere alimentato il “controllo” bensì la fiducia. Fiducia nella possibilità di rilassarsi senza perdersi; fiducia nella possibilità di ritrovarsi e rimettersi insieme (ritrovare le loro parti e rimetterle insieme) anche dopo che ci si è lasciati andare. Fiducia nella possibilità di “connettere” le cose, i pensieri, le sensazioni e le emozioni. Così potrà diventare possibile rilassarsi anche negli eventi sessuali e finalmente diventare possibile anche la scoperta del “piacere” della tenerezza. Un elemento diagnostico differenziale può infatti essere considerata anche la difficoltà ad abbandonarsi al rapporto sessuale e, come contrappunto e forse a conferma di questa affermazione, troviamo difficile notare schiette ed indubbie manifestazioni di panico nelle donne in gravidanza.
Terapia
Qualsiasi metodo utilizziamo nell’attuare una psicoterapia è influenzato dalle idee che abbiamo nei confronti del singolo. Nella favola di “Amore e Psiche”, la “fede” nel sentimento che Psiche prova nei confronti di Amore deve essere sufficiente e bastare perché il rapporto continui. La favola racconta della separazione che interviene quando Psiche cerca di “mettere gli occhi”, la coscienza, dove deve essere solo il cuore. Ma, contrariamente al luogo comune sapere, conoscere e amare non sono necessariamente antitetici; quando Amore diventa consapevole del proprio sentimento e smette di temere si ricongiunge all’amata. Allora forse il segreto sta nell’imparare a guardare dentro di sé piuttosto che nell’altro e riconoscere, nel senso di accettare, quello che ci troviamo così da scoprire che la fede è figlia della fiducia.
Nel DAP è questo il credito che maggiormente viene perseguito. Lavorando con persone affette da questo disturbo, si ha quasi sempre l’impressione che stiano cercando un sostegno, la forza di credere in loro stessi. A fronte degli impegni che si assumono, delle cose che fanno, delle disponibilità che mostrano, di fatto non credono in loro stessi. Forse proprio per questo s’impegnano al di là delle forze; per dimostrarsi diversi da come sentono di essere. È come fossero convinti che le cose fatte non abbiano il valore che meritano; che siano sempre cose di poco conto. Non hanno fiducia. Ciò che manca in queste persone è la fede e la fiducia e la fede e la fiducia testimoniano l’amore.
Sembrerà banale, ma è anche in questo senso che l’attacco di panico è la manifestazione di un problema di relazione. Queste persone sono in cerca, non dell’amore ma di essere amati; di qualcuno che le ami senza condizione, che gli faccia sentire e trovare la fede, che gli mostri e gli faccia sentire la fiducia. Di questi sentimenti hanno bisogno di appropriarsi e su questa dinamica psicologica nasce e si sviluppa la logica del gruppo di auto mutuo aiuto.
La domanda implicita del disturbo è in relazione alla dedizione, fiducia, gratuità, disponibilità; domande cui difficilmente può rispondere una figura professionale disponibile solo nelle ore di lavoro. Domande cui risponde in maniera più prossima invece un gruppo autogestito e autoformatosi.
Di questi bisogni è necessario tenere conto e un intervento, di qualunque tipo, rischia il fallimento se non si accompagna alla fiducia. È necessario che il terapeuta, lo psicologo e qualunque altro operatore credano nella possibilità che la persona che gli si rivolge ce la farà perché ha le qualità, le prerogative, gli attributi e le capacità per farcela a tenersi insieme, a rimanere “centrata” nelle avversità, a non perdersi, non disperdersi e non svuotarsi quando tanto e tante cose contemporaneamente richiederanno attenzione ed interventi.
Il DAP privilegia il corpo come teatro di manifestazione e penso che innanzi tutto del corpo dobbiamo accettare il dialogo. La mentalizzazione dovrebbe essere uno degli obiettivi terapeutici e una delle qualità di cui aver fiducia e a cui dare credito. La “mimetizzazione intellettuale e cognitiva” che è possibile osservare all’inizio di un’eventuale psicoterapia con queste persone, va considerata testimone degli sforzi che fanno per trovare la strada del “com-prendere”, del portare e mettere dentro di loro un certo modo di fare. È un tentativo di appropriarsi di un modo d’essere; un assecondamento che è un atto d’amore. Nella relazione devono però imparare a credere nell’esistenza di un modo d’essere personale che va cercato insieme piuttosto che creato; devono imparare ad abbandonarsi e lasciarsi andare ai movimenti spontanei del proprio organismo che in quest’allentamento potrà esprimersi in libertà e creatività. Devono essere rieducati alla fiducia in modo da smettere di aver paura di ciò che può accadere dentro di loro. Come Psiche dovranno imparare a “credere ciecamente” e perciò bisogna stare attenti a non illudere né deludere.
Un metodo terapeutico privilegiato per il DAP penso sia quello che prevede la possibilità di comprendere la problematica attraverso l’espressione corporea. Attraverso il corpo deve prevedere il suo esercizio così da metterne in evidenza le possibilità di modifica attraverso l’esperienza.
Noi siamo non solo le cose che pensiamo ma anche il modo in cui le pensiamo, siamo non solo il respiro e l’aria che ci entra dentro, ma anche il modo in cui prendiamo e utilizziamo quest’aria. Il “lasciarsi andare” e abbandonarsi, prima di diventare un’idea, è stata un’esperienza forse assimilabile anche a quella primaria di abbandonarsi nelle braccia di qualcuno; il panico prima di farsi parola ha invaso il corpo. Le “distonie neurovegetative” sono lo “scollamento” delle funzioni del nostro corpo che, sperimentate, testimoniano esperienzialmente l’incapacità a “tenersi insieme”.
Per questo penso che in psicoterapia debbano essere considerati un buon ausilio gli esercizi corporei che rimandano ai concetti di “equilibrio”, “coordinazione”, “centratura” e che propongono l’attenzione sensoriale privilegiando l’atteggiamento di accoglienza e fiducia. Rimane importante però non considerare questi esercizi alla stregua di semplici movimenti corporei; il loro senso va ricondotto alle valenze relazionali della relazione terapeutica perché si possano sperimentare, finalmente in una situazione “protetta” e accogliente, quegli eventi che sono diventati un’ombra persecutoria.
Riassunto
In questo articolo s’intende ipotizzare che gli eventi “attacchi di panico” siano generati dall’incapacità e impossibilità ad agire l’aggressività nei confronti delle prime persone significative. Dalla nascita l’Io si struttura rappresentando continui atti d’amore volti a queste persone. L’affetto, dato e ricevuto, diventa il collante di questa stessa struttura. È imperativo allora negare la rabbia; ma quando diventa impossibile, capita di poterla esprimere solo nei confronti di questo collante primario realizzando in tal modo diversi obiettivi. Nel DAP quindi, il controllo non è sempre e solo un’istanza super-egoica ma anche uno sforzo per “tenersi insieme”. [PAROLE CHIAVE: Disturbo da attacchi di panico, Tenersi insieme, integrazione/non-integrazione, fiducia, controllo]
Bibliografia
Goleman D., “Intelligenza emotiva, che cos’è, perché può renderci felici”, BUR, 2004, (pp. 126-127).
Ruggeri V., “L’esperienza estetica. Fondamenti psicofisiologici per un’educazione estetica”, Ed. Armando, 1997.
Ruggeri V., “L’identità in psicologia e teatro”, Ed. Magi, 2001.
Winnicott, D. W., “Dalla pediatria alla psicoanalisi”, Ed. Psycho Martinelli, 1991.
Giuseppe Ciardiello è Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta alla S.I.A.R.
S.I.A.R. (Scuola Italiana di Analisi Reichiana) scuola di specializzazione in psicoterapia autorizzata dal Ministero dell’Università. Elabora ed approfondisce le intuizioni di Wilhelm Reich. Ha come riferimento chiave l’unità psicobiologica dell’individuo e usa una metodologia articolata su più livelli: Analisi del Carattere, Vegetoterapia Caratteroanalitica che opera con acting corporei, e Analisi del Carattere della Relazione.
Dott. Roberto Cavaliere
Psicologo, Psicoterapeuta
Studio in Milano, Roma, Napoli e Vietri sul Mare (Sa)
per contatti e consulenze private tel.320-8573502 email:cavalierer@iltuopsicologo.it